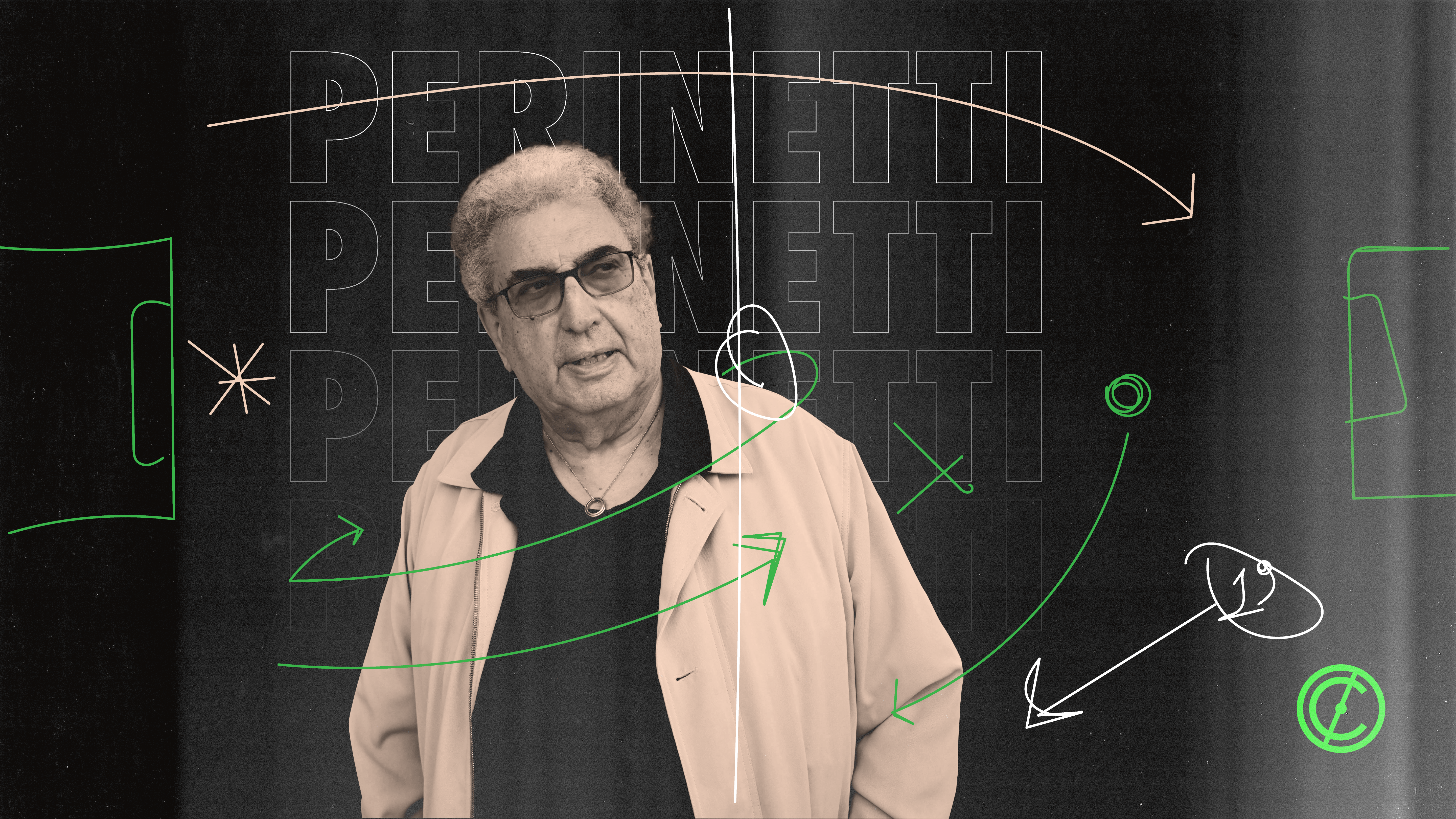Un gioco che racconta un mondo (perduto).
L’estate italiana è uno specchio identitario. Le lunghe giornate degradano lentamente in un tramonto mai così tardo, mentre le Grazielle sfrecciano sul lungomare sempre più affollato e le spiagge si riempiono di musica, di asciugamani, di bagni al mare. In questo frangente un suono crescente di palloni, scaraventati contro un muro, recuperati lontano, calciati di testa o di piede, comincia a riempire l’aria calda. Questo è il suono della “tedesca”. Del gioco che anima ciò che altrimenti resterebbe inanimato. Che scardina la monotonia degli sguardi persi negli smartphone persino d’estate. Si fonde con la tradizione dello Strapaese e del calcio “profondo” globale, ne solletica le viscere più profonde, le meno condizionabili.
Tra le zanzare, le pietre delle parrocchie, le piazze talvolta deserte. Oppure in campagna, tra campetti da calcio appena abbozzati, tra le vie del paese nell’umidità crescente, i bambini (e i più adulti) a volte per forza e a volte per scelta, si riuniscono con un pallone e le loro magliette da calcio per ottemperare al loro ultimo rito collettivo.
C’è chi rispolvera i propri cimeli calcistici e chi attinge alla propria inestimabile collezione di maglie. Non serve altro, oltre ovviamente alla palla. Perché il luogo è indifferente. A cambiare sono semmai solo le regole, sottoregole, eccezioni che rendono il calcio di strada un fenomeno antropologico complesso. La storia della “tedesca” si perde nella leggenda. Ha lo stesso valore delle saghe mitologiche o dell’epica classica che hanno accompagnato (spesso annoiato) quegli stessi giocatori da studenti nelle loro ore scolastiche. Non c’è neanche certezza sul nome. Per alcuni traducibile anche con “olandese” o “al volo”.
Nessuno sa quando sia iniziata, chi abbia cominciato a giocarci e abbia stabilito i suoi dogmi.
Unico precetto, scolpito nella pietra a memoria di ogni generazione di calciatori-di-strada è la certezza del tiro al volo, con il primo portiere che (comunque lo si scelga) ha un vantaggio di punti rispetto agli avversari e con l’obiettivo di eliminare questi ultimi uno per uno, scalando punti a ogni rete. Ai regolamenti si affiancano, stratificate, le tradizioni e le convenzioni. Nonché i vocaboli che fin dall’alba dei tempi codificano le esperienze umane, delineandosi in un vernacolo unico e spesso non direttamente traducibile in altre lingue.
Come la “spalletta”, emblema del gol (infame) capace di azzerare all’istante il punteggio del portiere di turno. Oppure come la “bastarda”, conferita al portiere raggiunta una certa soglia critica di punteggio. Per rendere pan per focaccia ai propri avversari, colpendoli direttamente con il proprio rilancio.
Allestita con mezzi di fortuna. Spesso persino senza una vera porta, con zaini, pali, ciabatte. In un numero di partecipanti che va da zero a infinito, nella “tedesca” scorre il sangue di un modo diverso e forse quasi scomparso di intendere il gioco del calcio alle nostre latitudini sportive, mentre ci si arrabatta alla ricerca del modo per salvare il mondo pallonaro italiano da quello che sembra ormai un ridimensionamento inevitabile. Un tracollo che è anche culturale e antropologico, che sostituisce l’individuo (come nel tennis) al collettivo del calcio, che al contempo traduce l’irrigidimento del sistema calcistico giovanile in un’asettica ricerca della vittoria in luogo del divertimento.
Quest’ultimo dovrebbe essere la prima regola, non scritta, di ogni sport di squadra o individuale, specialmente a livello giovanile. Al gesto tecnico anche sfrontato e senza pensieri oggi si sostituiscono la tattica e la fisicità (scambiata per tenuta fisica). Al genio subentra il buon giocatore, disciplinato e alto, strutturato.
La “tedesca” è residuo di quella genialità spesso irriverente e quasi smarrita. A fare punteggio non è la rete in sé ma il modo con il quale si segna. La coordinazione, lo slancio tecnico, la rovesciata, il colpo di tacco. Oppure la combinazione perfetta e collaborata, nota in gergo come “torretta”.
Ogni partita diviene epopea. Ricordo indelebile che premia la tecnica molto prima della disciplina.
Riportare indietro le lancette dell’orologio, auspicando che i bambini tornino a ripopolare i campetti e non solo, con le loro grida e i loro palloni, non è forse possibile in un tempo così veloce e così alienato. Tuttavia quello spirito permane. Tutto sta nel riaccogliere tali radici sportive, almeno nelle scuole calcio. Quelle del paese e del campanile, quella dei bambini che giocano a “tedesca” d’estate. Perché nessuna collettività che dimentichi le proprie radici ha modo di progettare il futuro. Nella vita, come anche nello sport. Come diceva Jorge Luis Borges: «Ogni volta che un bambino prende a calci qualcosa per la strada, lì ricomincia la storia del calcio».